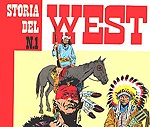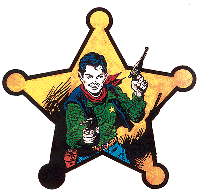di Alessandro Milani
In nessun altro paese, nemmeno negli Stati Uniti dove si è soliti collocare la nascita stessa dei comics e dove è nato il mito della Frontiera, si è avuto un successo forte delle avventure a fumetti ad ambientazione western come in Italia. Per cercare di scoprire il motivo del successo di Tex Willer e soci bisogna ripercorrere le tappe principali del genere western nel campo delle “nuvole parlanti”.
I primi a riportare nelle strisce racconti più o meno di fantasia legati all’immaginario dell’epopea americana furono i giornali statunitensi di inizio ‘900, da un lato ambientando nel West alcune storie di eroi dei fumetti già esistenti (per esempio Crazy Cat e Arcibaldo e Petronilla, per citare i più noti in Italia) e dall’altro creando nuovi protagonisti a tutti gli effetti western.
Viene solitamente riconosciuto in Lariat Pete, un cowboy valoroso che difendeva i più deboli con l’aiuto del proprio nipotino, il primo eroe della Frontiera. Siamo nel 1900 ma già tre anni dopo le sue avventure finirono, proprio mentre cominciava la prima stagione d’oro del western cinematografico: il 1903 fu l’anno dell’esordio dell’attore Broncho Billy Anderson, la star del western per antonomasia, al punto che un esperto frequentatore del genere come Clint Eastwood intitolò col suo nome (nel 1980!) un film dedicato ai miti del pionierismo americano.
Già questi anni segnarono per sempre le sorti del fumetto western made in Usa: al nascere di un sempre maggior numero di strisce ed  eroi di carta dalla vita (fumettisticamente parlando) breve, si affiancarono produzioni cinematografiche dal crescente successo, e furono queste ultime a portare avanti nell’immaginario statunitense il mito della Frontiera, soprattutto dopo l’avvento del sonoro.
eroi di carta dalla vita (fumettisticamente parlando) breve, si affiancarono produzioni cinematografiche dal crescente successo, e furono queste ultime a portare avanti nell’immaginario statunitense il mito della Frontiera, soprattutto dopo l’avvento del sonoro.
Proprio questa concorrenza “sleale” (in quanto a mezzi e impatto sul pubblico) del cinema portò però le avventure a fumetti a cercare nuove soluzioni e a toccare temi diversi da quelli dei western movies: mentre infatti i film, con i loro spettacoli d’azione e di abilità a cavallo, continuarono quella tradizione iniziata nell’800 con le horse operas, i rodei e gli spettacoli dei circhi (celeberrimi quelli di Buffalo Bill, giunto poi anche in Italia e del circense per antonomasia, Barnum), i comics cominciarono a tratteggiare meglio la psicologia dei personaggi, a prendere posizioni più vicine a quelle dei Nativi americani, e a descrivere in modo più realistico la vita degli abitanti della Frontiera, facendo anche tesoro dei reportages giornalistici e delle testimonianze dei diretti protagonisti.
Questo “aggiustamento di tiro”, per usare una metafora molto da cowboy, fu dovuto anche al fatto che, con la produzione
cinematografica in espansione e con il pubblico che abbandonava i vecchi eroi a fumetti, un precedente fallimentare tentativo dell’industria culturale statunitense era stato quello di sostituire le storie del Far West con altre di stampo meraviglioso/fantasy (che spesso finivano però per essere delle vere e proprie storie horror), che ebbero un enorme successo di pubblico ma che scatenarono nei loro confronti anche una fortissima pressione censoria, che avrebbe rischiato di far chiudere l’intera produzione fumettistica.
Tra le nuove storie di questo West de-mitizzato le più innovative vennero, come da tradizione, dalle rubriche di fumetti dei giornali: le strisce quotidiane o domenicali (solitamente anche a colori) ospitarono i personaggi più particolari (ironici pionieri alle prese con la vita di tutti i giorni, difensori degli indiani, ex militari) mentre gli albi continuavano a portare avanti anche le classiche storie d’azione.
Un po’ per il successo di questi nuovi anti-eroi di carta, un po’ per la visione del mondo di alcuni registi (Peckimpah e Arthur Penn per citare i grandi iniziatori) e in parte anche per il crescente aumento dei costi per le produzioni d’azione (business is business, del resto), anche il cinema virò in seguito (ma siamo nel secondo dopoguerra!) verso tematiche più apertamente sociali e verso l’introspezione psicologica dei personaggi: i diritti degli Indiani e l’avvento della società industriale sono tra i temi che segnarono la fine del mito della Frontiera così come era sorto a inizio secolo e i cosiddetti “Western crepuscolari” (due titoli su tutti: Sfida nell’alta Sierra di Peckimpah e Furia Selvaggia di Penn) diffusero la notizia della morte del mito del Far West al grande pubblico.
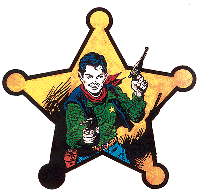
La caratteristica propensione per la serialità, tipica del fumetto, nel campo del western statunitense non coincise con una lunga vita
dei suoi protagonisti, né di carta né di celluloide, ma generò moltissime serie e questo fenomeno, nel momento in cui il nuovo media entrò nelle case degli americani, si trasmise immediatamente anche alle produzioni televisive. Invece di avere poche storie longeve si ebbero infatti numerosissimi serial (se ne possono contare quasi 200!) più o meno duraturi e più o meno di successo, alcuni dei quali con una successiva omonima versione a fumetti, che cercarono di portare avanti il più possibile, ognuna a suo modo, l’immaginario western, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, visto che molte di loro vennero presto esportate (il pubblico italiano giunse a conoscenza infatti di Laredo ,Bonanza , Zorro , David Crockett , Maverick , La casa nella prateria e molti altri).
In Italia la sostanziale differenza con gli Stati Uniti è data proprio dalla longevità del mito della Frontiera americana e di alcune storie western a fumetti in particolare.
Nato ufficialmente alla fine degli anni Trenta ma diffusosi soprattutto nel secondo dopoguerra il fumetto western italiano non ripartì certo dalle revisioni in chiave realistica operate in quel periodo negli Stati Uniti, ma da una visione mitica del Far West.
Non è un caso che il primissimo fumetto italiano di genere sia stato, nel 1935, “Ulceda, la figlia del Gran Falco della Prateria”, cioè una riduzione a fumetti di un omonimo romanzo di Salgari (l’autore fu l’illustratore Guido Moroni Celsi), che non aveva certo le caratteristiche di un veritiero romanzo storico; a esso seguirono altre versioni a fumetti di altri racconti “americani “ di Salgari (a opera di Rino Albertarelli) mentre storie originali ad ambientazione western, illustrate dal grande Walter Molino, trovavano spazio quasi esclusivamente su Il giornale di Salgari.
La chiave per capire la fortuna del genere western (non solo a fumetti) in Italia (ma anche in Europa e Sudamerica) credo sia
riconducibile proprio a questo “passaggio di testimone” tra il racconto popolare/avventuroso e il genere dei cowboys.
Infatti mentre negli Stati Uniti il mito della Frontiera occidentale era sì un mito ma anche una pagine fondamentale della storia locale e della memoria collettiva (e come tale condivisa al punto da poter variare sul tema in senso più o meno realistico), in Europa questo mito restava puramente mito. Anzi, poteva diventare “il mito” adatto a sostituire il caro vecchio romanzo di viaggi e avventure, in un’epoca nella quale il mondo era diventato “più vicino” e dove – purtroppo a causa della guerra – molti italiani erano entrati in contatto con popolazioni di tutto il mondo.
Come si sa la conoscenza di altre culture le arricchisce reciprocamente ma inaridisce i miti, soprattutto se legati a un esotismo da cartolina (quale era stato per molto tempo quello dettato dai romanzi salgariani e da pubblicazioni come Il Giornale Illustrato di Viaggi ). Dunque l’immaginario europeo e italiano in particolare aveva bisogno di nuova linfa, e la trovò nelle storie di un period
o che era estremamente lontano nello spazio, ma anche nel tempo (ricordiamo che storicamente l’epopea dei pionieri del Far West è collocabile tra il 1840 e il 1890), di modo che anche l’eventuale contatto con gli americani contemporanei non potesse in alcun modo “smentire” il nuovo mito che stava sorgendo.
Si accennava, a fianco di una longevità del genere western anche a un duraturo successo di pubblico per alcuni personaggi in particolare; anche questo fatto sembra essere chiaramente riconducibile alla visione classica del mito, che il più delle volte comprende un eroe.
Mentre se si vuole ricreare il clima di un’epoca si cerca di dare tutte le sfumature possibili di quello che in quell’epoca accadde, se si vuole invece rafforzare un’idea, un concetto, in questo caso un mito, la figura migliore è quella dell’eroe, incarnazione del bene contro le mille insidie del male e contro i casi sfortunati della vita.
Attorno a lui si può poi costruire anche un mondo, ma il punto fermo di questo mondo non sarà mai messo in discussione.
Questo procedimento, che è anzitutto un procedimento narrativo, porta facilmente all’affezione da parte del pubblico più per il personaggio (il suo carattere, la sua abilità, anche le sue debolezze) che per le sue vicende.

In Italia non si può parlare di Far West (in generale, non solo in campo fumettistico) senza fare riferimento a personaggi come Kit Carson, il Piccolo Sceriffo, Pecos Bill e soprattutto Tex Willer.
Anche per il Tex Willer di Gianluigi Bonelli si conferma la teoria della discendenza prettamente avventurosa del personaggio: infatti se la sua prima striscia “Il totem misterioso” comparve nelle edicole già nel 1948, egli fu anche, qualche anno dopo, nel 1956, il protagonista di un romanzo di avventure “Il massacro di Goldena”, sempre di Gianluigi Bonelli, naturale prosecuzione creativa delle precedenti opere dell’autore, dai significativi titoli di “Il Crociato nero”, “Le tigri dell’Atlantico” e “I fratelli del silenzio”, usciti tra il 1936 e il 1940, che portavano avanti l’avventura di ambientazione medievale (il primo), quella di ambientazione esotica (il terzo) e il romanzo di guerra (il secondo). Lo stesso Gianluigi Bonelli dichiarò anni dopo di essere stato un divoratore dei libri di Jack London, Edgar Wallace, Zane Grey (il quale si era cimentato a sua volta nel fumetto western negli Stati Uniti) e dei film d’avventura americani, senza tralasciare i maestri narratori italiani, tra i quali stravedeva per Yambo e il solito Salgari. Le fortune di Bonelli furono due: la prima (legata a filo doppio alla sua bravura) fu quella di diventare dapprima direttore di testate famose (esempio Il Vittorioso) e poi editore in proprio (la sua prima casa editrice si chiamava, visti i tempi, Audace), avendo così la possibilità di dare spazio a quel tipo di storie (a fumetti e no) che più lo appassionavano e sulle quali stava lavorando personalmente, e la seconda fu quella di incontrare il disegnatore giusto per portare a compimento queste storie a fumetti: Aurelio Galleppini. Il loro sodalizio durò a lungo e segnò la fortuna della serie e del personaggio di Tex.
A fianco di Tex Willer, dagli anni 50 a oggi si sono affiancati altri personaggi significativi del mondo del fumetto italiano, dai già citati Pecos Bill e Piccolo Sceriffo a Capitan Miki al Grande Blek, alcuni dei quali con un discreto successo di pubblico; per lungo tempo però il fumetto western italiano non mise in discussione a livello di contenuto.
L’unica variante al tema classico dell’eroe buono (che spesso esce anche dal contesto “storico-geografico” nel quale è nato per andare  in zone ancora più esotiche: ad esempio Tex ha avventure fino persino in Polinesia!) è quindi spesso data da suoi alter-ego comico/satirici. A fianco dei fumetti-western classici nascono così una serie di personaggi che vivono le loro avventure divertenti nel Far West: da Lucky Luke (del belga Morris ma che ebbe grande successo in Italia) a Pedrito El Drito di Antonio Terenghi fino al celeberrimo Cocco Bill di Jacovitti.
in zone ancora più esotiche: ad esempio Tex ha avventure fino persino in Polinesia!) è quindi spesso data da suoi alter-ego comico/satirici. A fianco dei fumetti-western classici nascono così una serie di personaggi che vivono le loro avventure divertenti nel Far West: da Lucky Luke (del belga Morris ma che ebbe grande successo in Italia) a Pedrito El Drito di Antonio Terenghi fino al celeberrimo Cocco Bill di Jacovitti.
L’esistenza di versioni parodistiche e caricaturali degli eroi del West è però funzionale ancora una volta alla diffusione e perpetuazione del mito della Frontiera: salvo rare e recenti eccezioni (ad esempio Magico Vento con le sceneggiature di Gianfranco Manfredi) infatti il mito non fa i conti con se stesso e non viene messo in discussione, così come avvenuto negli Stati Uniti. In Italia, al massimo, appunto con le parodie, si giunge a mettere in discussione la figura dell’eroe, ma il mito della Frontiera resiste; parallelamente l’industria culturale statunitense (si pensi soprattutto a quella dell’entertainment e in modo particolare al cinema hollywoodiano) non sembra essere ancora pronta a far uscire da un visione stereotipata temi e periodi storici precipuamente “europei” quali la Grecia classica, l’Impero romano e il Medioevo, senza parlare della pressoché totale inattendibilità storica dei film basati sui classici delle letterature antica e medievale.
Ognuna delle due culture (che soprattutto in questo ambito sono difficilmente raggruppabili sotto la comune denominazione di “cultura occidentale”) si tiene stretto il proprio esotismo (con gli stereotipi a esso legati) e continua a ripropor-selo. Il problema sorge quando il fruitore di questa rappresentazione non ha altri mezzi a disposizione per conoscere la verità storica che giace oltre il mito o quando l’industria culturale si propone di rendere universali dei processi storico-mentali assolutamente esclusivi del proprio paese.
Articolo già pubbicato su “erewhon, arti, letteratura, scienze”.


















 Enzo Jannacci e da Ornella Vanoni, di quel “me Milan”, rigorosamente di genere maschile, che sembra proprio destinato a scomparire come una spettrale falce di luna in cielo quando viene giorno.
Enzo Jannacci e da Ornella Vanoni, di quel “me Milan”, rigorosamente di genere maschile, che sembra proprio destinato a scomparire come una spettrale falce di luna in cielo quando viene giorno.