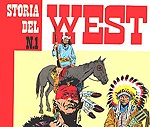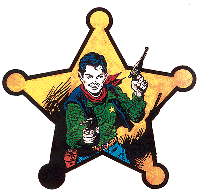di Martino Negri
di Martino Negri
Alice cominciava a non poterne più di stare sulla panca accanto alla sorella, senza far niente; una volta o due aveva provato a sbirciare il libro che la sorella leggeva, ma non c’erano figure né dialoghi, «e a che serve un libro», aveva pensato Alice, «senza figure e senza dialoghi?» [1]
Il libro dei nonsense di Edward Lear, finalmente pubblicato da Einaudi in edizione economica [2], con testo a fronte, è una raccolta di brevi componimenti in versi accompagnati da altrettante vignette disegnate dall’autore, alle quali i primi sono indissolubilmente legati. Caratterizzati da una medesima, rigorosa struttura compositiva e da un gusto letterario eminentemente ludico, i limericks – come sono universalmente conosciuti, sebbene Lear non li abbia mai chiamati in tal modo [3]– si inseriscono nella ricca tradizione britannica della letteratura nonsense: scevra da ogni impegno di natura didascalica o morale e intesa piuttosto al puro diletto degli occhi e del pensiero.
Lear iniziò a disegnare «buffi animali e omini, spesso accompagnando i disegni con versucoli scherzosi, che rappresentano il seme delle future rime nonsensical»[4], negli anni ’30 dell’Ottocento, a uso e consumo dei nipoti e pronipoti di Lord Stanley, dodicesimo conte di Derby, dal quale aveva ottenuto l’incarico di raffigurare gli animali che vivevano nel serraglio della sua tenuta di Knowsley Hall.
Pubblicati tra il 1846 (A Book of Nonsense) e il 1871 (More Nonsense, Pictures, Rhymes, Botany, etc.), ilimericks di Edward Lear, o learics come alcuni li chiamano [5], sono considerati un classico della letteratura britannica per l’infanzia.
Il merito di Lear fu quello di portare a una più rigida codificazione, nonché a una maggior diffusione, una forma letteraria che affondava le sue radici nella tradizione orale – filastrocche, ninna-nanne – ma che aveva, già al suo tempo, conosciuto l’onore della carta stampata; tra il 1820 e il 1822 erano infatti comparsi tre volumetti di poesie illustrate che presentavano la struttura metrica e i temi tipici dellimerick leariano: The History of Sixteen Wonderful Old Women, illustrated by as many engravings: exhibiting their principal Eccentricities and Amusements (1820), Anecdotes and Adventures of Fifteen Gentlemen (1821) e Anecdotes and Adventures of Fifteen Young Ladies (1822)[6], i quali si inserivano nel contesto dello straordinario sviluppo che la prima editoria illustrata di massa – appoggiata «sull’invenzione e la messa a punto della litografia e sul perfezionamento della tecnica riproduttiva delle incisioni su legno» [7]– ebbe proprio nel terzo decennio del XIX secolo.
Il limerick, dunque – inteso come forma poetica mista di versi e disegni, con caratteristiche formali e tematiche riconoscibili e costanti – esisteva già molto tempo prima che Lear cominciasse a scriverne, anche se furono proprio i suoi a decretare il definitivo successo e la straordinaria diffusione del “genere”. Consistenti in singole strofette di cinque righe[8], con versi a ritmo giambico anapestico – comune nella poesia ‘umoristica’ inglese – e schema di rime aabba, ilimericks hanno tre versi di tre piedi (i primi due e l’ultimo) e due più brevi, di soli due piedi (terzo e quarto verso).
There was an Old Person of Pinner,
As thin as a lath, if not thinner,
They dressed him in white,
And roll’d him up tight,
That elastic Old Person of Pinner. [9]
Ogni composizione introduce un personaggio bizzarro che agisce o patisce situazioni che esorbitano dalla sfera della logica e del buon senso comune, lasciando il lettore di stucco. L’eccentricità di comportamenti o situazioni è il perno intorno al quale ruota il meccanismo del divertimento; ma a innescarlo sono il tono del racconto – «ovvio, tranquillo, privo di qualsiasi moto di stupore» [10] – e la presenza dei disegni, che danno corpo visibile al cortocircuito logico suggerito dalle parole. Significativo, in questo senso, appare il titolo della più antica raccolta dilimerick conosciuta – la già citata Storia di Sedici Meravigliose Vecchiette, illustrate con altrettante incisioni: le quali mostrano le loro principali Eccentricità e Spassi – nel quale è sottolineata l’importanza che in tale forma poetica assumono sia l’elemento visivo (le incisioni, tante quante sono le storie) sia il motivo dell’eccentricità, ovvero di una distanza dalla norma che disorienta e produce allegria, divertimento. Lear stesso decise di aprire il suo primo volume di rime ‘senza senso’ con un limerick che pare quasi una dichiarazione di poetica:
 There was an Old Derry down Derry,
There was an Old Derry down Derry,
Who loved to see little folks merry;
So he made them a book,
And with laughter they shook
At the fun of that Derry down Derry.[11]
Egli dunque non inventò il “genere”: si limitò piuttosto a perfezionare ciò che la tradizione gli offriva, limitando le varianti possibili allo schema di base e accompagnando i versi con illustrazioni stilizzate e surreali, connotate – in senso espressivo – assai più di quelle presenti nelle prime raccolte pubblicate. Ed è facile notare come la maggior parte dei limericksleariani non solo segua rigorosamente lo schema di rime e il ritmo stabiliti dalla tradizione, ma utilizzi anche alcune “formulae verbali” – come le chiama Marco Graziosi – ricorsive e limitate [12].
Il primo verso introduce il personaggio, del quale – o della quale – è generalmente indicato il luogo di provenienza o quello in cui si sviluppa la sua azione:
a) There was an Old Man of the Hague,
b) There was an Old Man in a Marsh
Nel secondo verso trova spazio la caratterizzazione del personaggio, del quale si raccontano abitudini insolite o particolarità fisiche e d’indole:
a) Whose ideas were excessively vague;
b) Whose manners were futile and harsh;
Terzo e quarto verso sono in genere strettamente narrativi, assumendo addirittura, spesso, la forma dialogica: mentre il primo e il secondo verso offrono una visione in qualche modo extra-temporale del personaggio, questi ultimi lo collocano in un punto preciso del tempo, il momento cruciale della sua fulminea esistenza, quello, anzi, in cui il suo destino pare compiersi e trovare un senso o, ancor meglio, un ‘non senso’.
a) He built a balloon
To examin the moon,
b) He sate on a Log,
And sang Songs to a Frog,
L’ultimo verso, infine, ricalcato sul primo, chiude la composizione riportando l’attenzione sul personaggio, al quale viene ora attribuito un aggettivo nel quale, come in un emblema, sia racchiusa la sua natura più profonda.
a) That deluded Old Man of the Hague.[13]
b) That instructive Old Man in a Marsh. [14]
 Significativa – tra le ‘formule verbali’ ricorrenti – quella iniziale, ‘There was…’: presente in tutti i limericksleariani, la sua funzione è la stessa che riveste, nelle fiabe di ogni tempo, l’espressione italiana del “C’era una volta…” [15] , ovvero di introdurre il lettore in un mondo altro, una dimensione parallela ma distanziata nello spazio e nel tempo, in cui non vigono le categorie, immaginative e razionali, alle quali abitualmente ci si attiene.
Significativa – tra le ‘formule verbali’ ricorrenti – quella iniziale, ‘There was…’: presente in tutti i limericksleariani, la sua funzione è la stessa che riveste, nelle fiabe di ogni tempo, l’espressione italiana del “C’era una volta…” [15] , ovvero di introdurre il lettore in un mondo altro, una dimensione parallela ma distanziata nello spazio e nel tempo, in cui non vigono le categorie, immaginative e razionali, alle quali abitualmente ci si attiene.
L’universo in cui vivono i personaggi di Lear, infatti, è «l’incongruità trionfante. È l’assurdo trasportato in un’atmosfera poetica. È una felice vacanza dal mondo dei sensi, un rapido scorcio d’un altro mondo…»[16].
Un rapido scorcio di un altro mondo, scrive John Boynton Priestley, utilizzando un’espressione che se da un lato sottolinea l’immediatezza, la rapidità con la quale Lear riesce a tratteggiare i suoi personaggi – la cui vita pare condensarsi in un unico gesto o avventura emblematici – dall’altro induce alla tentazione di accostarlo a un suo contemporaneo francese, inventore anch’egli di universi paralleli: Grandville, che dava alle stampe il suo libro più complesso, il celebre e bellissimo Un autre monde, nel 1844, giusto un paio d’anni prima del Book of Nonsense di Lear.
Fitta, in entrambi, la presenza di pesci, uccelli e altre bestie con i quali una varia umanità interagisce, dando vita a situazioni paradossali, o ai quali le persone finiscono per assomigliare [17]: eppure Lear non si serve degli animali, come invece fa Grandville, per portare avanti un discorso fortemente polemico – per quanto stemperato dalla satira – nei confronti della società del suo tempo [18].
Legata senza dubbio alle inclinazioni personali dell’artista, che fin dalla prima giovinezza s’era distinto per le sue abilità nella raffigurazione del mondo zoologico, la forte presenza di animali nei limericksleariani è dovuta anche, io credo, al peso di una tradizione favolistica millenaria nella quale – si pensi anche solo a Esopo, oppure a Fedro – proprio loro sono i protagonisti delle storie: con la differenza che nessuna intenzione didascalica, moralistica o pedagogica, muove l’estro di Lear, per il quale parole e figure sono semplicemente trampolini di lancio per qualche felice capriola del pensiero.
There was an Old Man who said, ‘Hush!
I perceive a young bird in this bush!’
When they said, ‘Is it small?’
He replied, ‘Not at all!
It is four times as big as the bush!’ [19]
Oppure
There was an Old Person of Skye,
Who waltz’d with a Bluebottle Fly:
They buzz’d a sweet tune,
To the light of the moon,
And entranced all the people of Skye. [20]
 Nel 1861 A Book of Nonsense venne pubblicato in edizione ampliata e fu accolto con straordinario favore dal pubblico: tale successo segnò la consacrazione definitiva della forma poetica e dell’uomo che l’aveva saputa coltivare e distillare, Edward Lear, consideratone spesso non solo il maestro, ma addirittura l’inventore. Da quel momento in poi il genere ha conosciuto sempre più estimatori, e non solo fra i comuni lettori, ma anche fra i grandi della letteratura contemporanea, che ne sperimentarono spesso, e con gusto, anche la declinazione erotica o addirittura triviale [21]:
Nel 1861 A Book of Nonsense venne pubblicato in edizione ampliata e fu accolto con straordinario favore dal pubblico: tale successo segnò la consacrazione definitiva della forma poetica e dell’uomo che l’aveva saputa coltivare e distillare, Edward Lear, consideratone spesso non solo il maestro, ma addirittura l’inventore. Da quel momento in poi il genere ha conosciuto sempre più estimatori, e non solo fra i comuni lettori, ma anche fra i grandi della letteratura contemporanea, che ne sperimentarono spesso, e con gusto, anche la declinazione erotica o addirittura triviale [21]:
There was a young plumber of Leigh
Who was plumbing a girl by the sea.
She said: “Stop your plumbing,
there is somebody coming!”
Said the plumber, still plumbing, “It’s me!” [22]
In qualche misura debitore di Lear è persino, io credo, l’americano Tim Burton, che nel 1997 pubblicava The Melancholy Death of the Oyster Boy & Other Stories, uno scarno volumetto di poesie illustrate che si presenta come una galleria tragicomica di creature allucinate ed emarginate, delle quali sono raccontate le vicende amare e straordinarie: ogni poesia introduce un personaggio ed è accompagnata da uno o più disegni dell’autore, a seconda della sua lunghezza [23];ma se in Lear ogni cosa pare fatta d’aria e di luce, di scintilla e di sorriso (anche laddove la morte fa la sua comparsa), in Burton è tutto ctonio e caliginoso, intriso d’angoscia esistenziale e solitudine:
There once was a morose melonhead,
who sat there all day
and wished he were dead.
But you should be careful
about the things that you wish.
Because the last thing he heard
was a deafening squish. [24]
E d’altra parte, lo humour che pervade i suoi versi tende a essere tetro più che nero, a volte persino raccapricciante:
The Boy with Nails in his Eyes
put up his aluminium tree.
It looked pretty strange
because he couldn’t really see. [25]
 In Italia la fortuna del limerick è iniziata molto più tardi che in Inghilterra, naturalmente. I pochi che ne conoscevano l’esistenza li facevano girare tra gli amici[26], componendone magari a loro volta, soprattutto di salaci, ma fu proprio Carlo Izzo, traduttore nonché curatore dell’edizione tascabile Einaudi, a darne per primo notizia al pubblico, nel 1935, sul numero di novembre dell’Ateneo Veneto:
In Italia la fortuna del limerick è iniziata molto più tardi che in Inghilterra, naturalmente. I pochi che ne conoscevano l’esistenza li facevano girare tra gli amici[26], componendone magari a loro volta, soprattutto di salaci, ma fu proprio Carlo Izzo, traduttore nonché curatore dell’edizione tascabile Einaudi, a darne per primo notizia al pubblico, nel 1935, sul numero di novembre dell’Ateneo Veneto:
E fu ancora Izzo a portare a compimento la prima traduzione in lingua italiana di tutti i limericks del poeta britannico, pubblicata nel 1946 dalla casa editrice Il Pellicano di Vicenza con il titolo di Il libro delle follie [27]; nel 1954 l’editore fiorentino Neri Pozza – che un paio d’anni più tardi avrebbe pubblicato la prima edizione della Bufera di Montale – ne rimise in circolazione [28]le copie invendute, ritirate poco tempo prima dall’editore vicentino che aveva chiuso i battenti.
Nel 1970, infine, Einaudi ripubblicò la traduzione di Izzo – con testo originale a fronte – nella prestigiosa collana “I millenni”, sancendone definitivamente il successo anche nel bel paese [29]: nella stessa collana figuravano i maggiori classici della letteratura per l’infanzia, dalle favole di La Fontaine alle fiabe dei fratelli Grimm, da L’isola del tesoro di Stevenson alGiro del mondo in ottanta giorni di Verne [30].
Era stato nell’autunno tragico del 1943 che Izzo, su sprone di alcuni amici[31] aveva deciso d’imbarcarsi nel progetto della traduzione completa dei limericksleariani, trasformando in una sorta di dovere morale quello che fino a quel momento era stato solo un divertimento privato, un’occasione, tutt’al più, per amicali buffi parlamenti. Nel dicembre dello stesso anno aveva già terminato la traduzione. Una traduzione che è diventata, a sua volta, un “classico” della nostra letteratura, nonostante l’inevitabile perdita – nel passaggio alla lingua italiana – di tutta una serie di elementi di natura ritmico musicale nei quali risiede una parte non certo esigua del fascino originario dei limericks.
Perché leggere, oggi, le poesie nonsensical di Edward Lear? Raccontano ancora qualcosa della realtà che ci circonda? L’hanno mai fatto? Non lo so. Eppure sono convinto che leggere – o rileggere – oggi Il libro dei nonsense potrebbe rivelarsi una sana operazione di igiene mentale: viviamo in un’epoca in cui l’oppressione dell’individuo si manifesta in forme più sottili e subdole di quando un gruppo d’amici convinceva un giovane studioso di letteratura inglese a tradurre un’opera folle e intraducibile. Il pregio maggiore del volume di Lear è forse proprio quello di essere semplicemente un libro, un bel libro scritto con piacere, con amore per le parole e i disegni. Punto.
«Ehi! – direbbe molto probabilmente Alice – Ci sono dialoghi… e anche figure!»
Cosa si può desiderare di più da un libro?
Note
1 L. Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, Milano, Longanesi, 1971, p. 27.
2 E. Lear, Il libro dei nonsense, Torino, Einaudi, 2004. Il volume è stato curato e tradotto da Carlo Izzo.
3 Lear chiamava queste sue composizioni nonsense rhymes o anche nonsense rhymes and pictures; e d’altra parte, la parolalimerick compare per la prima volta – a quanto scrive l’Oxford English Dictionary – in una lettera di Aubrey Beardsley nel 1896, quando Lear era già morto da alcuni anni.
4 C. Izzo in E. Lear, op. cit., p. XIX.
5 Learic deriva dalla fusione di Lear e di lyric (che in inglese significa poesia, lirica) e vorrebbe indicare un genere di poesia – il limerick appunto – avvertita come specificamente leariana; non dimentichiamo, tuttavia, che i limericks non rappresentano che una porzione della ben più ampia produzione letteraria e figurativa dell’autore.
6 Tutte le informazioni sulla storia e l’evoluzione del limerickcome forma poetica sono desunti dal saggio di Marco Graziosi e da altri suoi contributi presenti nel sito: www.nonsenselit.org/Lear/index.html.
7 A. Negri, Grandville, in Grandville, Un autre monde, Milano, Mazzotta, 1982 (ristampa anastatica dell’omonimo volume pubblicato nel 1844), p. V.
8 A volte, per fare economia di spazio i versi vengono stampati in tre righe, accorpando il primo col secondo e il terzo col quarto, oppure in quattro, unendo solo il terzo col quarto: in tali casi, naturalmente i versi neonati presenteranno una rima al mezzo.
9 «C’era un vecchio di Corfù/ Sottile come un’asse e forse più;/ Gli misero un càmice bianco/ E lo arrotolarono su tutto quanto,/ Quell’elastico vecchio di Corfù». ». E. Lear, Il libro dei nonsense, cit., pp. 256-7.
10 C. Izzo, Umoristi inglesi, Torino, Eri, 1962, p. 71.
11 «C’era un vecchio Din Din di Rindini/ Cui piaceva veder ridere i bambini;/ Fece allora un bel libro coi pupazzi,/ Fin che risero tutti come pazzi/ Alle trovate di quel Din di Rindini». E. Lear, Il libro dei nonsense, cit., pp. 2-3.
12 Graziosi nota, ad esempio, che l’aggettivo old (vecchio) è quasi invariabilmente associato a man (uomo) o person(persona), laddove young è sempre associato a lady (signora) o, in alternativa, a person; person – prosegue – è la variante bisillabica di man, utilizzata da Lear per ragioni di natura ritmica e metrica quando la parola che indica il luogo di provenienza è monosillabica o bisillabica ma accentata sulla prima sillaba (l’assenza di una variante monosillabica per lady spiegherebbe a questo punto la predominanza di figure maschili nei limericksleariani). La prima linea – conclude Graziosi – segue dunque uno schema semplice e rigoroso nella stragrande maggioranza dei casi (88 su 112 in A book of Nonsense e 84 su 100 in More Nonsense, Pictures, Rhymes, Botany, etc.):
There was a(n) Old Man of X
Young Lady
Person
13 «C’era un vecchio di Praga/ Dalla mente quanto mai vaga;/ Costruì un aeronave di fortuna/ Per osservare la luna,/ Quell’illuso vecchio di Praga». E. Lear, Il libro dei nonsense, cit., pp. 150-1.i>
14 «C’era un vecchio di Palude/ Di natura futile e rude;/ Seduto su di un rocchio/ Cantava stornelli a un ranocchio,/ Quel didattico vecchio di Palude». Ivi, pp. 258-9.
15 Dal “C’era una volta” delle fiabe tradizionali, che già Collodi, nella seconda metà dell’Ottocento, citava come formula costituita (e in questo senso possibile oggetto di parodia, oppure variazione) – «C’era una volta… – Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno.» – all’analoga espressione ingleseOnce upon a time… con la quale si apre – nel contesto della mitologia contemporanea – una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi, quella di Star Wars: «Once upon a time/ in a galaxy so far…». G. Lucas, Star Wars, Twentieth Century Fox, 1977.
16 J.B. Priestley, citato in C. Izzo, Umoristi inglesi, cit., p. 75.
17 Ciò accade in 37 limerick su 109 nella sua prima raccolta e in 39 su in 103 nell’ultima. Sarebbe interessante a questo proposito indagare se Lear avesse maturato interessi fisiognomici analoghi a quelli goethiani o se semplicemente si divertisse a rimarcare i tratti comuni di uomini e bestie.
18 «Animali vestiti da uomini raccontano i vizi, le passioni, le debolezze, le idiosincrasie del tempo. Ma dietro il tono da favola, che oggi più facilmente si coglie, le tavole di Grandville erano già ricche di allusioni politiche così precise da essere immediatamente vietate dalla censura». A. Negri, op. cit., p. V.
19 «C’era un vecchio di Brusuglio/ Che scoprì un uccellino in un cespuglio;/ Quando gli chiesero: «È ancora da nido?»/ «No, davvero! – rispose indispettito – / È quattro volte più grande del cespuglio!». E. Lear, Il libro dei nonsense, cit., pp. 158-9.
20 «C’era un vecchio di Ripatransone/ Che valzeggiava con un moscone:/ Zufolavano amabili ballate/ Sotto la luna d’estate,/ E incantavano tutta Ripatransone». Ivi, pp. 420-1.
21 Scrissero limericks persino James Joyce e Isaac Asimov.
22 «C’era un giovane idraulico di Leigh/ che stava impiombando una ragazza in riva al mare./ “Fermati – disse la ragazza –/ qualcuno sta venendo!”/ Rispose l’idraulico, senza fermarsi, “Sono io!”». Si tratta di un limerick che si regge principalmente sul meccanismo del doppio senso: da quello più banale del verbo to come (venire), a quello difficilmente traducibile del verbo to plumb, che significa sia ‘impiombare’ ovvero ‘sigillare con il piombo’ (il termine, tecnico, è legato al mestiere dell’idraulico, ma è anche ampiamente utilizzato, in senso metaforico, per indicare l’atto sessuale), sia ‘scandagliare’ ovvero ‘misurare la profondità’ di qualcosa, che arricchisce la scena con ulteriori sfumature di senso. È stato attribuito a William Cosmo Monkhouse (1840-1901), autore di svariate raccolte di versi, tra le quali una intitolata proprioNonsense Rhymes (London, R. Brimley Johnson, n. d.), illustrata da Gilbert Chesterton.
23 A differenza dei limericks leariani, le poesie di Tim Burton non rispettano un rigoroso schema compositivo né ritmico e hanno lunghezze molto variabili.
24 «C’era una volta una cupa testa di melone/ che se ne stava seduta tutto il giorno/ desiderando d’essere morta./ Ma bisogna fare attenzione/ con le cose che si desiderano./ Perché l’ultima cosa che sentì/ fu un assordante squish». Melonhead, in T. Burton, The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories, New York, Morrow, 1997, pp. 94-5.
25 «Il ragazzino con i chiodi negli occhi/ montò il suo albero di alluminio. / Aveva un aspetto assai strano/ perché egli, in verità, non poteva vedere». The Boy with Nails in his Eyes, in T. Burton, op. cit., pp. 22-3.
26 Fosco Maraini, ad esempio, racconta di averli usati come espediente per tener desta l’attenzione dei suoi allievi d’inglese, i cadetti dell’Accademia Navale di Livorno. Cfr. F. Maraini, Case, amori, universi, Milano, Mondadori, 1999, p. 260.
27 Ne furono stampate solo mille copie, centocinquanta delle quali numerate e rilegate.
28 Con una nuova copertina.
29 Altre traduzioni italiane sono quelle di Renato Bellabarba (Nonsensi, Roma, G. Bardi, 1961) e Ottavio Fatica (Limericks, Roma-Napoli, Theoria, 1994; Einaudi, 2000); nel 1972 era anche uscita un’edizione Einaudi con illustrazioni di Luciana Rosselli (Poesie senza senso, Torino, Einaudi, 1972).
30 E d’altra parte, con il diffondersi del genere, anche l’Italia, come tutti gli altri paesi del mondo, ha conosciuto estimatori dellimerick salace. Tra i tanti, l’ubiquo Federico Gobbo, fondatore – al principio degli Novanta – della Società dei Poeti Viventi: percelebre addirittura il suo limerick dedicato all’amica di Nonna Speranza di gozzaniana memoria: «Ormai vecchia e rugosa è l’amica/ di Nonna Speranza, grommata la fica/ dal gusto un po’ amaro/ ch’appasta i baffi, raro/ aroma antico d’anziana e d’amica».
31 Tra i quali anche il futuro editore Neri Pozza: si tratta di Aldo Camerino, Manlio Dazzi e Antonio Pellizzari. Izzo ne parla in un passo della sua introduzione al volume. Cfr E. Lear, Il libro dei nonsense, cit., pp. XXII-III.
 Oppure abbiamo una seconda ipotesi: quella di cercare di capire di più quale servizio e quale comunicazione offrono, ai morituri e a tutti noi curiosi, i signori della Gaia Funeral.
Oppure abbiamo una seconda ipotesi: quella di cercare di capire di più quale servizio e quale comunicazione offrono, ai morituri e a tutti noi curiosi, i signori della Gaia Funeral. Le onoranze funebri al massimo offrono soluzioni più o meno economiche e più o meno “di classe” (qui lo humour nero è tutto loro), magari per sottolineare lo status della famiglia (come succedeva una volta con il carro con i cavalli bardati di nero). Oppure le scelte riguardano aspetti “accessori” come i tributi floreali al defunto (“non fiori, ma opere di bene”) e la scelta o meno per la cremazione (anche qui con varie possibilità, sulle quali si rimanda alla scena de Il Grande Lebowski dei fratelli Cohen relativa alla scelta dell’urna per le ceneri).
Le onoranze funebri al massimo offrono soluzioni più o meno economiche e più o meno “di classe” (qui lo humour nero è tutto loro), magari per sottolineare lo status della famiglia (come succedeva una volta con il carro con i cavalli bardati di nero). Oppure le scelte riguardano aspetti “accessori” come i tributi floreali al defunto (“non fiori, ma opere di bene”) e la scelta o meno per la cremazione (anche qui con varie possibilità, sulle quali si rimanda alla scena de Il Grande Lebowski dei fratelli Cohen relativa alla scelta dell’urna per le ceneri).